Il processo penale e il processo mediatico
- Avv. Giorgio Altieri

- 10 mag 2022
- Tempo di lettura: 5 min
Il processo mediatico è il processo celebrato sui mezzi di informazione. Un processo parallelo e alternativo al processo vero e proprio davanti al giudice, con regole e tempistiche completamente diverse. Il processo mediatico si svolge per lo più sui media, in televisione, sui giornali e oramai sui social. I commentatori, convinti di conoscere i fatti, non conoscono gli atti processuali. Eppure, con notevole disinvoltura e superficialità ricostruiscono e il più delle volte distorcono i fatti, pronunciando sentenze in nome del “pubblico sovrano”.
I giudizi sono basati su sensazioni, congetture, presunzioni, esigenze di copione e, a volte, addirittura non dichiarati interessi personali. In alcuni casi, si giunge ad anticipare sui media le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, gli esiti di valutazioni tecniche, a ricostruire cinematograficamente i dialoghi, le dinamiche e gli eventi. Non è raro che i testimoni o pseudo tali vengano richiamati dalla notorietà delle telecamere e, in alcuni casi, finanche dal pagamento di lauti compensi per interviste o ricostruzioni che si rivelano poi magari destituite di fondamento. Non è infrequente che quei pseudo testimoni complichino spesso, a tal punto, il processo da ritrovarsi inquisiti per falsa testimonianza. Per altro verso, si arriva al paradosso che, nell’esame in contraddittorio in dibattimento, l‘accusa o la difesa, invece di riferirsi agli atti delle indagini, formulano contestazioni in aula basandosi su dichiarazioni rese in interviste televisive.
È noto, poi, in tutti i manuali di diritto e di psicologia criminale come la testimonianza sia un mezzo di prova infido, non sempre genuino, non necessariamente per “mala fede”, ma perché la memoria è di per sé stessa fallace e facilmente condizionabile.
Quando si racconta qualcosa, lo si fa ogni volta in modo diverso. Di regola, una persona riesce a registrare solo il 20% di quello che vede. In caso di eventi fortuiti, quella percentuale diminuisce, in quanto non ci aspetta che quell’evento accada e di solito la scena che si coglie si limita a pochi istanti o frammenti dell’evento. Inoltre, si verifica l’effetto conosciuto come “cecità del cambiamento”, legato all’incapacità di visualizzare i dettagli che caratterizzano lo svolgersi di un accadimento. Non si ricorda solo ciò che si è vissuto direttamente, ma si memorizzano anche le aspettative, ossia le conoscenze e i contenuti che sono stati acquisiti da altre esperienze precedenti. Si aggiungono poi i condizionamenti esterni, il “sentito dire” che sembra rafforzare il ricordo, ma in realtà lo altera.
Nel caso di processi mediatici, dunque, la voglia di esserci, di diventare protagonisti diviene uno stimolo psicologico fortissimo in grado di condizionare – anche in buona fede – il ricordo. Sintomatico è il progressivo “aggiustamento” delle dichiarazioni che mutano nel tempo e ancora di più tra la fase delle indagini preliminari e il dibattimento.
Anche i difensori contribuiscono spesso al processo mediatico, non solo per accrescere la loro notorietà professionale, ma anche per introdurre elementi a favore delle parti rappresentate oppure a sfavore delle controparti, per stimolare approfondimenti che magari l’accusa non sta svolgendo e per cercare di condizionare il favore dell’opinione pubblica verso lo specifico interesse difensivo.
Accade finanche che la stessa Polizia Giudiziaria e i Pubblici Ministeri intervengano in conferenze stampa, rappresentando mere ipotesi investigative come se fossero sentenze definitive, così alimentando e condizionando la “macchina mediatica” che si appassiona alle indagini e, ancor di più, può arrivare ad incidere sui concreti sviluppi delle vicende processuali.
Un altro paradosso è che il nostro sistema processuale era evoluto con il codice del 1989 verso la centralità del dibattimento, individuato come sede destinata alla acquisizione e formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Eppure, l’attenzione dei media, rispetto al passato quando il processo era inquisitorio e interessava i media nella fase dibattimentale, è oggi focalizzato sulle indagini e spesso ancor prima, già al momento dell’arresto o dell’informazione di garanzia.
Nonostante sia (o dovrebbe essere) centrale il dibattimento, l’orientamento dell’opinione pubblica si forma ben prima dell’opportuno e necessario approfondimento processuale, quando ancora “tecnicamente” si discute di meri indizi anziché di prove. Lo stillicidio di notizie parcellizzate, in spregio al segreto investigativo, riguardo alle dichiarazioni delle persone informate dei fatti, a stralci di conversazioni oggetto di intercettazione, agli estratti di relazioni di consulenti, alle impressioni ed illazioni degli “ospiti” della trasmissione televisiva di turno, diventa esso stesso “prova”, trasformando l’indagato in colpevole o innocente, a seconda del “tifo organizzato” nella trasmissione televisiva o sui social tra innocentisti e colpevolisti. Il risultato è che la persona accusata del fatto verrà prima condannata o assolta sui media e solo successivamente interverrà una decisione giurisdizionale, secondo le regole proprie del processo penale.
Nei sistemi di common law, la diffusione sulla stampa di notizie riguardanti un processo in corso non è solo lesivo dell‘immagine e della reputazione dei singoli e della loro privacy, bensì integra il reato di contempt of Court (disprezzo della Corte), perché entra in conflitto diretto con le regole del processo accusatorio.
È fin troppo evidente come il processo mediatico arrivi quindi ad inquinare il processo vero e proprio. Si parla sempre di “verità processuale” che tende a ricostruire per quanto possibile la “verità storica”. Nel processo mediatico non si può neppure parlare di tendenza, in quanto la verità storica si annacqua, si confonde, spesso svanisce e forte è il rischio che non si arrivi ad alcuna verità. Ciò non solo in danno di un processo fair e della giustizia, ma anche e soprattutto degli interessi primari della vittima che il processo dovrebbe tutelare.
Nonostante le numerose esperienze di inaccettabile interferenza del processo mediatico sul processo tradizionale, in Italia si assiste tutt’oggi alla levata di scudi dei paladini della cronaca giudiziaria che denunciano come un intollerabile bavaglio qualsiasi proposta di arginare l’invadenza dei media.
In tutta Europa valgono le regole della Corte di Strasburgo, secondo cui l’imparzialità dei tribunali garantita dall‘art. 6 CEDU non consente ai giornalisti di formulare dichiarazioni che risulterebbero idonee, intenzionalmente o meno, a ridurre le chances di un individuo di beneficiare di un processo equo (sentenza Worm c. Austria, 29 agosto 1997) e tali da scalzare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia.
Sempre la CEDU (nella sentenza Allet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995) ha stabilito come l’attività di informazione dei mezzi di comunicazione di massa rispetto a procedimenti penali in corso debba essere svolta “con tutta la discrezione e con tutto il riserbo imposti dalla presunzione di innocenza”.
Il nostro paese resta invece sul piano mediatico “l’isola dell’ingiusto processo”. È allora evidente che occorre ripensare profondamente l’equilibrio tra i due principi fondamentali della nostra Costituzione che vengono invocati dall’una o dall’altra corrente di pensiero, l’art. 21 sulla libertà di informazione e l’art. 27 sulla presunzione di innocenza.
Non è questa la sede per affrontare un dibattito così complesso. Qui basti una considerazione legata all’esperienza comune. Chiunque si trovi coinvolto in un’indagine e poi in un processo dovrebbe essere giudicato per ciò che ha fatto realmente e non andare incontro a una gogna mediatica che ha spesso un impatto irrimediabile e devastante sulla persona e sugli affetti più cari.
Seguendo l’insegnamento più intimo dell’interpretazione kantiana della giustizia, come equità, è stato affermato che la libertà è agire in accordo con la legge che noi stessi ci diamo, che deve condurre a un’etica del mutuo rispetto e della stima di sé. Già questo dovrebbe essere di per sé sufficiente per comprendere come sia inevitabile che la libertà di informazione debba auspicabilmente recedere rispetto alla presunzione di innocenza. Ciò significa ricondurre l’esercizio del diritto di informazione alla sua funzione propria di controllo e di verifica del corretto esercizio della giurisdizione, garantendo il rispetto che va riservato sia alla vittima che all’indiziato, salvaguardando il più possibile l’obbiettivo neutro della ricerca della verità per poter, solo in tal modo, affermare realmente la giustizia.
Avv. Giorgio Altieri – Tonucci & Partners

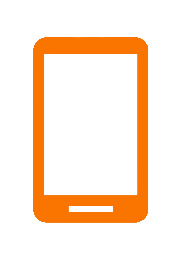



Commenti