LA CONFIGURAZIONE DI ARTIFICI E RAGGIRI NELLE TRUFFE ONLINE
- Avv. Tiziana Ronchetti

- 24 mag 2022
- Tempo di lettura: 5 min
La maggiore disponibilità dei sistemi informatici hanno indotto noi tutti a ricorrere sempre più frequentemente a siti e-commerce per incontri romantici, soprattutto in questi tempi di restrizioni negli spostamenti e di isolamento sociale determinati dalle misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In tale contesto, non manca occasione in cui ci si ritrovi vittima di inganni e di raggiri, sia per la mancata consegna dei prodotti acquistati, sia per l’eventuale richiesta di denaro da parte di persone che abbiamo conquistato la nostra fiducia facendo leva sulle comuni fragilità.
Tale ipotesi potranno configurare gli estremi della truffa, ai sensi dell’articolo 640 del Codice penale, laddove ricorrono artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare sentimenti, fatti o circostanze tali che, ove realmente conosciuti, avrebbero indotto il soggetto passivo ad astenersi dal disporre del proprio patrimonio.
L’idoneità dell’artificio o del raggiro, quali presupposti del reato di truffa, deve essere valutata facendo riferimento alle particolari circostanze del fatto e alle sue modalità esecutive, dovendo risultare un nesso causale tra azione ed evento, senza che rilevino la mancanza di diligenza, il controllo e la verifica da parte della persona offesa.
È quindi necessario accertare che la condotta posta in essere sia causa di artifici o raggiri atti a conseguire un ingiusto profitto, inducendo la vittima a compiere scelte patrimoniali che, alla luce della realtà dei fatti, non avrebbe effettuato.
Secondo la Suprema Corte il reato si considera integrato con la mancata consegna della merce acquistata e pagata nel caso in cui, ad esempio, venga indicato un falso luogo di residenza del venditore o ancora nel caso in cui lo stesso arrivi a far cancellare il proprio account per ostacolare le operazioni indirizzate alla sua identificazione.
La mancata osservanza da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate, unita a condotte artificiose idonee ad influenzare le scelte del contraente tanto da generare un danno con relativo ingiusto profitto, determina la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p..
In tale contesto, l’utilizzo della rete da parte dei truffatori rappresenta un’aggravante del reato, di cui all’art. 640 nel comma 2, n. 2-bis, in quanto nella distanza dal luogo del commesso reato rispetto al luogo ove si trova l’altro contrante, secondo la prassi tipica di simili transazioni, è ravvisabile una minorata difesa dell’ignaro contraente. D’altronde, la vendita di beni, tramite portale internet, si fonda proprio sull’affidamento del compratore nell’offerta ivi pubblicizzata e nella descrizione delle caratteristiche e qualità del prodotto in vendita.
Quindi, gli artifici e i raggiri quale presupposti della condotta criminosa consistono in tutti quei fattori volti a trarre in inganno il contraente ad esempio attraverso una puntuale descrizione del bene a cui non segue la consegna del bene stesso.
La truffa quale reato istantaneo e di danno si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica, da parte dell’autore, abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. Ne consegue che nell’ipotesi di c.d. truffa contrattuale il momento consumativo del reato si realizza non già quando il soggetto passivo assume l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento di un bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ad esempio nel momento di “riscossione della somma versata attraverso un bonifico bancario con accredito su conto corrente” e non in quello in cui viene data disposizione di pagamento da parte della persona offesa. Invero, in caso di pagamento mediante ricarica di una carta prepagata, il conseguimento del profitto da parte di questo ultimo si verifica nel momento stesso in cui la parte che è stata tratta in inganno ha proceduto al versamento del denaro.
Nel primo caso la competenza territoriale spetta all’ufficio nel quale è stato conseguito il profitto e cioè nel luogo in cui risulta essere presente il conto corrente intestato al truffatore, cosiddetto domicilio informatico. Nel secondo caso, invece, la competenza spetta al Tribunale del luogo dove l’acquirente ha effettuato la ricarica della carta prepagata.
La Giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, risultando dalla sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, non essendo necessario verificare l’idoneità in astratto dei mezzi usati, ma quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore.
Alla stessa stregua, con riferimento alle cosiddette “truffe romantiche”, la condotta truffaldina viene individuata non solo nel simulare sentimenti d’amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l’aspetto della verità ed a trarre in errore.
Con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte d’appello di Brescia che condannava l’agente in ordine al reato di truffa per avere, con artifizi e raggiri, - consistiti nell’avviare una relazione sentimentale con la persona offesa, di molto più grande, nel proporle falsamente l’acquisto in comproprietà di un appartamento, nel richiederle prestiti proponendole la cointestazione di quote societarie - indotto in errore la persona offesa circa l’effettivo acquisto dell’immobile e sulla situazione economica della propria società, facendosi consegnare ingenti somme di denaro, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa.
Il ricorrente, richiamando la sentenza del Tribunale di Milano del 14.7.2015, osservava come avrebbe dovuto accertarsi la volontà ingannatoria sin dall’inizio, altresì dovendosi provare il rapporto consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.
Nel ricostruire l’elemento oggettivo del reato, si deve tenere presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore: artifizi o raggiri; induzione in errore; atto dispositivo; danno patrimoniale e profitto ingiusto.
Si sottolinea in particolare che, ai fini dell’individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l’idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed il nesso causale tra l’inganno e l’errore della vittima, la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato (sentenza n. 25165/2019).
La condizione di solitudine, negli ultimi tempi, hanno portato sempre più spesso le persone ad affidarsi ai siti di incontri o a cercare semplice compagnia in Rete. Pertanto, non ci sorprende che queste tipologie di truffe si realizzino maggiormente nel contesto della rete e dei social network, ove risulta facile reperire informazioni utili sulla vittima al fine di poter meglio circuire la sua psiche e raggiungere la loro piena fiducia per poi richiedere somme di denaro o altri beni.
Le vittime, a seguito di tali truffe, subiscono conseguenze emotive e patrimoniali devastanti e spesso non denunciano l’accaduto per il timore di essere giudicati per l’inganno subito.
Emerge, quindi, la necessità di perfezionare lo strumento di controllo dei sistemi informatici, ma soprattutto l’esigenza di di sviluppare una maggiore consapevolezza nel loro utilizzo, onde evitare spiacevoli circostanze.
Avv. Tiziana Ronchetti

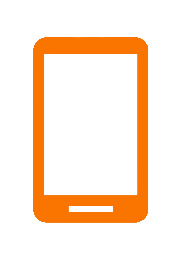



Commenti